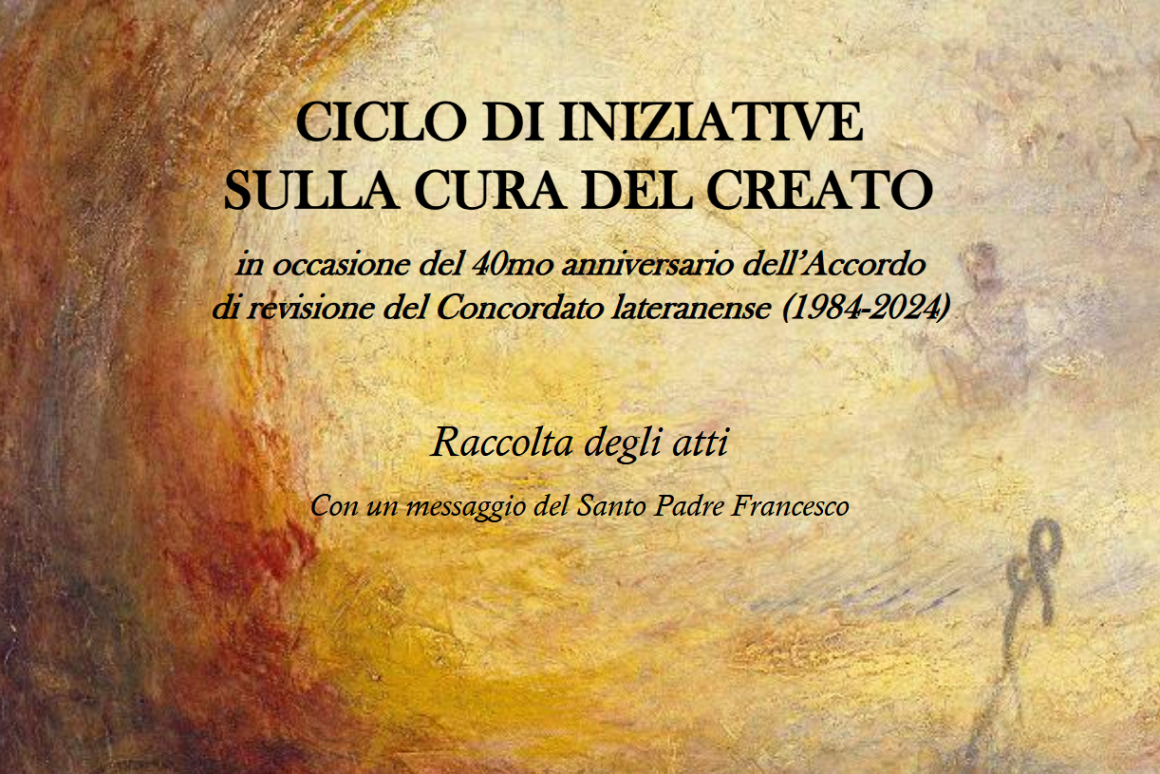3.5 Prof. Davide Rondoni, Presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’VIII
centenario della morte di San Francesco di Assisi
Buongiorno a tutti,
Non mi ritengo un Professore, ma solo un poeta, e forse proprio in qualità di poeta sono stato
invitato in questa occasione per parlare del Cantico, una poesia che ci ha lasciato Francesco. Il
Santo, infatti, non usa parole standard, bensì sceglie la ricchezza di un testo lirico, a testimonianza
della sua stima per l’umanità. Il Comitato, che io presiedo, ha lo scopo di onorare la morte di San
Francesco e si dedica a progetti stabili e duraturi nel tempo, poiché San Francesco non ha bisogno
di promozione. Per esempio, faremo un grosso intervento per la Biblioteca di San Francesco nel
Convento di Assisi allo scopo di digitalizzare e permettere lo studio nei prossimi secoli di questi
testi; inoltre, ho commissionato ad alcuni artisti contemporanei 10 nuove statue di San Francesco
affinché il linguaggio artistico continui a parlare di lui; il Comitato ha anche proposto un progetto
per armonizzare tutte le esperienze relative all’itinerario del Cammino dedicato al Santo, tramite
una Fondazione o un ente apposito che possa gestire, pianificare e organizzare gli interventi di
conservazione e assistenza, promuovendo produzioni creative e culturali sulla narrazione del
pellegrinaggio francescano.
Inoltre, vorrei sottolineare gli elementi di collegamento tra il Cantico e l’attualità: per prima cosa, il
Creato è visto come un segno in cui Francesco riconosce – come Lucrezio, Leopardi, e Mario Luzi
– che la natura non è buona o cattiva in sé, ma dipende da come la si guardi. Lo sguardo di
Francesco, molto simile a quello dei trovatori (poeti provenzali itineranti nelle corti feudali del XII-
XIII secolo), è uno sguardo povero, umile, che riconosce nella natura il segno del possesso di
qualcun altro, proprio come i trovatori amavano la donna di un altro. Questa influenza provenzale
si ritrova nel nome stesso di Francesco, cresciuto dalla madre francese. Guardare la realtà come
possesso di un altro è il simbolo della vera povertà, significa saper guardare il mondo poveramente.
D’altronde, persino Giacomo Leopardi è francescano, molto più di quanto insegni la scuola: per
esempio, ne La Ginestra, utilizza il termine “mendico” per descrivere l’atteggiamento –
“mendicante” – di un uomo di fronte alla natura, cioè consapevole del fatto che non gli appartiene,
come le “donne lontane” ammirate nella poesia provenzale. Su questa consapevolezza si radica il
Cantico di Francesco, che richiama la differenza tra possedere e amare, estremizzandola, lodando
l’amore per la natura, conscio che quest’ultima sia segno della grandezza del Creato. Questa
distinzione tra amore e possesso è un tema ancora estremamente attuale.
In secondo luogo, l’uomo in questo Cantico è qualificato da una strana caratteristica: il perdono.
Questo atto, il più gratuito che esista, invita inevitabilmente a riflettere sulla natura umana,
soprattutto in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sembra averla svalutata Oggi, più che mai,
dovremmo rispondere alla domanda che Leopardi pose nel 1830: “E io che sono?”11. Come sembra
suggerire Francesco, l’unicità dell’essere umano – non replicabile da un algoritmo – sta nella sua
strana e assurda libertà di perdonare, in quello che Montale descriverebbe come uno “sbaglio di
natura”, “l’anello che non tiene”12.
Come ultimo elemento di collegamento voglio citare nuovamente Dante, che non sbaglia mai,
quando fa dire a San Domenico nel Canto XI del Paradiso: non basta dire “Assisi”, non basta dire
“ascesi” – giocando un po’ con le parole – bisogna dire “oriente”. Oriente ovviamente è “orior”,
da dove sorge il sole, omaggio all’Alter Christus, come viene chiamato Francesco, per la potenza
della sua proposta, della sua santità; però, Oriente vuol dire anche un’altra cosa oggi, in questo
momento storico in cui ci vogliono convincere che c’è una guerra tra Oriente e Occidente, mentre
in realtà c’è una “guerra tra supermercati”, per la moneta, non per motivi spirituali e culturali, ed è
importante saper cogliere la distinzione. E la nostra terra è il ponte dove si incontrano Oriente e
Occidente, perché il monachesimo e il cristianesimo sono fenomeni orientali, traslati in Occidente,
e ciò produce una grandissima responsabilità non solo culturale, ma anche politica e civile. Il motivo
per cui Francesco viene ascoltato dal Sultano, da cui era andato in missione per convertirlo durante
le Crociate del 1219, è perché viene riconosciuto in quanto monaco, uomo di Dio, pur venendo
dal campo nemico. In questo contesto caratterizzato dai conflitti, e in cui l’umanità si sente smarrita,
è necessario parlare di Francesco, non solo per il suo anelito di pace, ma anche per questo suo
ruolo di “ponte” tra le culture.
Grazie